Il "Non" Rifugio antiaereo nel
Bastione di
Porta Guccia a Palermo

"Quando suonava la sirena si doveva raggiungere il
ricovero più vicino...
Spesso erano delle trappole...
senza vie d’uscita se non quella d’ingresso..."
Non c’è gioia più grande che ricevere le e-mail per posta
elettronica dopo aver messo in rete un nuovo pezzo, scoprire
che occhi attenti e critici si sono soffermati sul tuo sito
è la ricompensa più grande. Raccontare fatti e mostrare
luoghi sconosciuti ai più, suscitando forti emozioni ,
riportare alla mente di chi legge i ricordi che si
ritenevano perduti mi entusiasma e mi invoglia a continuare
con passione lo studio per una materia poco conosciuta e
poco trattata. Tra tante e-mail una in particolare mi ha
colpito, quella del Prof. T. Guarrata, leggendola ho colto
tutta l’emozione che ha provato nel ricordare i tristi
momenti della guerra condivisi con gente a lui sconosciuta
in un ricovero antiaereo. Da ciò è nata l’idea di rendere
partecipe il protagonista inserendo il suo articolo nella
"Palermo Sotterranea" preceduto da una breve presentazione
del luogo dove si svolsero i fatti.
Su Corso Alberto Amedeo strada che riprende il tracciato
dell’antico fossato delle mura cinquecentesche, è visibile
il Bastione della Balata o del Papireto, che faceva parte
assieme al bastione di S. Giacomo al bastione del Palazzo
Reale e al non più esistente bastione d’Aragona, al sistema
murario cinquecentesco occidentale.
Il Bastione ha la forma pentagonale alto tra i sei e gli
otto metri. Sopra il bastione fu eretto il Palazzo del
Marchese Guccia con un giardino pensile, eretto alla fine
del XVIII secolo quando gran parte dei bastioni furono
venduti dal Demanio ai privati.
Al palazzo si accede dal
vicolo Cuccia ad angolo della via Papireto a confine col
convento delle Cappuccinelle dove in un locale seminterrato
fu realizzata la nuova sepoltura delle monache.

L’ingresso al vicolo

Il muro perimetrale del convento

L’ingresso al palazzo
Il sistema viario faceva parte originariamente del
complesso militare del bastione. Percorsi pochi metri
dall’inizio del vicolo ci si trova davanti l’ingresso del
palazzo riconoscibile dal grande portone e dalle insegne
della famiglia Cuccia.
Varcata la soglia si trova un piccolo cortile dove alla
sinistra trovasi una fontana una volta riccamente ornata;
dal cortile si diparte un doppio scalone che porta ai piani
nobili con ricchi saloni decorati ed affrescati, da dove è
possibile accedere al giardino pensile fatto costruire dal
marchese, ed è qui che si trova la Torretta Belvedere dove
nel periodo bellico, si sarebbe dovuta montare una
postazione di mitragliatrici antiaerea.

Il piccolo altare

La Torretta Belvedere
Fortunatamente non fu istallata, data la vicinanza col
Palazzo Reale, il quale avrebbe potuto subire gravissimi
danni.Alla base della rampa destra dello scalone si trovano
le tracce di accesso a quello che una volta era il locale
adibito a ricovero……Ma facciamo parlare il protagonista...

L’ex ingresso al ricovero

Il Prof. Guarrata indica l’ingresso al ricovero
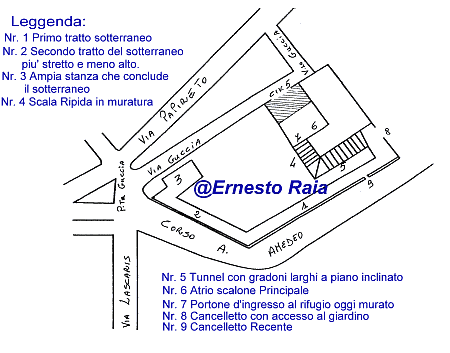
Il sotterraneo si estende sotto il bastione, oggi a
livello stradale, tra il corso A. Amedeo e Porta Guccia.
Le pareti ed il soffitto a botte sono in pietra mentre il
calpestabile dei tratti 1,2,3 (identificati nella piantina),
è in terra battuta. Si accede dalla via Guccia, al numero
civico 5, attraverso un ingresso (oggi murata) situato alla
destra della scala principale, nell’atrio del palazzo. Il
dislivello tra la via Guccia e il corso A. Amedeo fa si che
la parte bassa del sotterraneo si debba raggiungere mediante
una scala ripida in muratura,stretta e senza ringhiera,
composta da circa quindici gradini (zona nr.4) alla sinistra
della scala ora descritta si allarga un tunnel discendente
con gradoni ampi ed a piano inclinato per cui la discesa qui
diventa agevole (zona nr.5). La parte terminale della
scalinata del tunnel porta già al piano stradale di corso A.
Amedeo. Mediante un pianerottolo, da destra, seguendo il
perimetro del bastione, si accede ai camminamenti del
sotterraneo (zone 1,2, e 3 ).
Unica via d’uscita , oltre all’ingresso, un piccolo
cancello in ferro (parte terminale della zona nr.8) che
portava in un giardino, non visibile dalle vie esterne,
situato tra il bastione, il corso A. Amedeo e la via
Cappuccinelle. Tale giardino fu poi la sede dell’allora
arena cinematografica A. Amedeo. Oggi vi si trovano
magazzini o siti artigianali e la via d’accesso è un grande
cancello in ferro in corso A. Amedeo proprio adiacente alla
parete esterna del bastione.

L’accesso al sotterraneo

Scorcio del sotterraneo
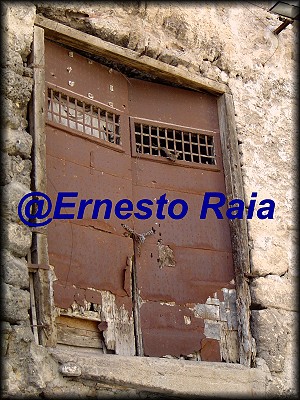
Vecchio magazzino per la
lavorazione delle corde.
Da recente l’intera parete della fortificazione è stata
ripulita e illuminata per cui il sito è evidenziato anche a
livello turistico. Nell’occasione dei recenti lavori di
restauro venne praticata una piccola via d’ingresso al
sotterraneo protetto da un cancelletto in ferro da dove è
possibile osservare lo spessore della parete del bastione e
la larghezza del camminamento.
Un pò di storia...
Il
camminamento sotterraneo venne utilizzato come rifugio
antiaereo nel secondo conflitto mondiale (1940-44), prima
dagli abitanti del civico 5 della via Guccia, tra cui molti
sfollati che, in funzione del " rifugio" avevano preso
alloggio anche nelle vecchie scuderie del palazzo.
Successivamente il rifugio si allargò agli abitanti delle
vicine vie Papireto, Cappuccinelle e Noviziato.
Assunse così la funzione di ricovero pubblico senza che
ne avesse le caratteristiche per la mancanza di una via
d’uscita sicura. La custodia del sotterraneo era affidata al
capo fabbricato, Don Totò, che si avvaleva dei collaboratori
più giovani di lui. Il loro compito principale era quello di
rendere praticabili i camminamenti o parti di essi, per
consentire ospitalità ad un numero crescente di rifugiati
durante le incursioni aeree; installare, ove possibile, la
luce elettrica per ridurre l’uso di candele, acetilene e
lumini vari che bruciavano una considerevole quantità di
ossigeno, non facilmente ricambiabile. Ogni famiglia, in
linea di massima, si attribuiva una zona fissa ove sistemava
panche e sedie o quanto altro riteneva opportuno.
Le parti utilizzate del sotterraneo come ricovero furono
quelle che nello schema sono segnate col numero 1 e metà del
camminamento segnato col numero 2. Nel 1943, durante
un’incursione aerea, fu deciso da parte di un gruppo di
rifugiati di esplorare il restante camminamento, reso
inaccessibile da cumuli di materiale da riporto, da
infiltrazioni d’acqua che rendevano fangoso il terreno e da
ostacoli vari che impedivano, anche a persone di piccola
statura, di mantenere la posizione eretta. L’esplorazione
comportava l’uso di torce funzionali che garantissero la
luce. Dopo alcuni giorni, approfittando di una ennesima
incursione aerea, si portò a compimento l’esplorazione e si
scoperse che il camminamento culminava in una grande stanza
senza uscite zona 3 della cartina.
...il 9 maggio 1943, era domenica, durante lo storico
bombardamento diurno (erano le ore 12) effettuato da
cinquecento fortezze volanti americane, il rifugio antiaereo
mostrò tutti i suoi limiti di agibilità perché si affollò
oltremodo per un numero insolito di rifugiati che,
terrorizzati dal prolungarsi ininterrotto del bombardamento
, vi cercarono scampo. In quella occasione si rischiò lo
stritolamento reso più sinistro dal tremare della terra,
dallo spostamento d’aria causato dalle esplosioni delle
bombe di grosso calibro cadute vicine, dalla mancanza di
energia elettrica e dal pigia pigia che non consentiva di
accendere le candele di fortuna.
Quanto detto è la
testimonianza di T. Guarrata, allora tredicenne...