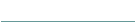












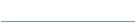
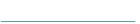






 |
|
a cura di C. Ossequio
|
Le
isole Eolie, Lipari soprattutto, sono sempre state identificate
come le isole del dio Eolo, che accolse Ulisse nella sua reggia e
gli donò l’otre dei venti perché potesse tornare in patria
senza incorrere in altri pericoli. Ma al di là della loro
immagine leggendaria, esse hanno avuto un ruolo centrale nella
storia del mondo mediterraneo.
Fino
alla seconda guerra mondiale dell’archeologia delle isole Eolie
non si conosceva molto, né erano stati fatti scavi sistematici,
fatta eccezione per gli scavi non documentati eseguiti nel 1800 e
l’indagine archeologica condotta da Paolo Orsi nel 1928, in cui
era stata scoperta, a Lipari, la necropoli in contrada Diana e al
di sotto della quale erano stati individuati gli strati risalenti
al Neolitico.
Le
prime ricerche sistematiche, condotte da Luigi Bernabò Brea e
Madeleine Cavalier, tra il 1946 e il 1950, si realizzarono a
Panarea e poi anche a Stromboli e Filicudi.
Lipari
fu per anni inavvicinabile, essendo stata lager
fascista e poi luogo in cui esiliare gli stranieri indesiderati in
Italia, fino a che nel 1950 l’isola non fu più impiegata come
luogo di confino e gli archeologi poterono finalmente scavare.
Furono
iniziati scavi sistematici che immediatamente mostrarono la
ricchezza del sito mostrando una stratigrafia che va dal Neolitico
(4000 a.C.) fino all’età moderna.
Da
allora le indagini archeologiche furono regolari, seguite da studi
e pubblicazioni, i numerosissimi reperti vennero a costituire il
Museo Archeologico Eoliano, nella stessa Lipari, oggi dedicato al
più grande studioso delle Eolie, Luigi Bernabò Brea.
Le
isole Eolie sono state importanti nella storia del Mediterraneo, a
partire dall’epoca Neolitica (IV – III millennio a.C.), quando
Lipari commerciò dovunque l’ossidiana, un vetro vulcanico di
colore nero lucente, molto tagliente, usato per fabbricare lame e
raschiatoi.
I
siti preistorici di Lipari danno il nome a varie fasi culturali
contraddistinti da produzioni ceramiche particolari:
Stile di Serra d’Alto: prodotta intorno alla metà del IV
millennio a.C. Si tratta di ceramica molto depurata con una
decorazione miniaturistica, con i motivi del meandro e della
spirale.
Stile di Diana: prodotta tra la fine del IV e gli inizi del III
millennio a.C. Si tratta di ceramica monocroma di colore rosso.
In
questo periodo parte da Lipari il popolamento alle isole di
Panarea e Filicudi.
In
seguito si registrò una crisi nel commercio dell’ossidiana, che
fu sostituita dall’uso del metallo (fasi dette di Piano
Conte e Piano Quartara).
Tra
il 1600 e il 1250 a.C., in piena età del Bronzo, le isole Eolie
vissero un nuovo periodo di prosperità, grazie al nuovo ruolo che
ebbero a ricoprire come emporio commerciale nel mondo miceneo
(Fase detta di Capo Graziano).
Nel
XV secolo a.C. le isole furono testimoni di enormi cambiamenti
testimoniati dall’uso di nuovi stili ceramici. Queste
trasformazioni paiono additabili all’arrivo di nuove genti,
riferibili alla facies
culturale detta del
Milazzese, dal nome di un villaggio posto nell’isola di
Panarea, caratterizzato da materiali di questa fase.
Nel
XIII secolo a.C. nuove genti invadono le isole, segnando
cambiamenti sostanziali nella loro vita. I villaggi delle isole
minori vennero distrutti e non saranno più ricostruiti, dagli
scavi si individuano, infatti, chiare tracce di incendio e di
distruzioni violente.
Solo
a Lipari seguirono altre fasi di vita che la legano alla penisola
italiana e alla Sicilia, mentre si interrompono i rapporti con le
altre isole.
Segue
la fase cosiddetta dell’Ausonio (divisa in Ausonio I e II),
proveniente dalla penisola (come tramandatoci da Diodoro Siculo,
sebbene sotto forma di leggenda), i cui villaggi nacquero sui
villaggi della fase precedente, che ebbero modo di distruggere.
La
necropoli riferita a questa fase è stata scoperta nel 1953 in
Piazza Monfalcone e consiste in tombe a cremazione, le cui ceneri
erano raccolte entro situle, a loro volta inseriti in grossi
pithoi in cui erano conservati scheletri rannicchiati.
Come
si può comprendere, i villaggi, dato il clima estremamente
pericoloso, sorsero per lo più in posti naturalmente fortificati,
nel caso di Lipari, sul Castello, uno sperone roccioso a picco sul
mare.
Anche
questa fase venne distrutta nel IX secolo a.C.,
Seguì
un periodo di estrema povertà e disfacimento, in cui l’isola di
Lipari rimase deserta, fatta eccezione, forse, per qualche piccolo
nucleo sparso per l’altipiano. Infatti, narra Diodoro Siculo,
che quando nel 580 a.C. i Cnidi giunsero nell’isola di Lipari
per colonizzarla vi trovarono solo pochi abitanti, che si
definivano discendenti del re Eolo.
I
Greci furono bene accolti dagli indigeni che vivevano nel timore
delle incursioni degli Etruschi, e stabilirono un governo
collettivistico, in cui alcuni coltivano la terra e altri la
difendono. Solo in un secondo momento, di relativa calma, le terre
vennero divise e vennero colonizzate le altre isole. I Liparoti
riportarono anche molte vittorie sui loro vecchi e temuti nemici,
gli Etruschi, e nel IV secolo a.C. è all’apogeo della sua
potenza. Nonostante tutto nel 304 subiscono un saccheggio da parte
di Agatocle, tiranno di Siracusa.
Con
la decima parte del bottino conquistato nelle loro vittorie sugli
Etruschi fu eretto un ex-voto nel santuario di Apollo a Delfi, in
Grecia, di cui restano ancora testimonianze sul terreno.
Durante
la prima guerra punica Lipari si schiera a favore dei Cartaginesi
e divenne una loro base strategica, per questa ragione subì
continue incursioni da parte dei Romani, finché fu distrutta da
questi nel 251 a.C.
Da
questo momento Lipari non conobbe più un periodo glorioso e
florido. Riacquistò importanza durante il conflitto tra Sesto
Pompeo e Ottaviano, quando venne fortificata e poi ancora, visse
una relativa prosperità sotto Augusto, con l’invio di nuovi
coloni.
Poco
si sa dell’isola nell’era cristiana, solo che fu sede
vescovile almeno fino al III secolo d.C.
L’antico
nome dell’isola pare che fosse Meligunis,
in seguito si chiamò Lipàra,
ma è ricordata nell’Odissea col nome di isola Eolia.
L’insediamento
più antico della città greca di Lipari sorse sulla rocca del
Castello, o Cittade, secondo i locali, ma dopo poco tempo per l’aumento della
popolazione l’abitato si allarga alla piana sottostante, e viene
racchiuso in una cinta muraria costruita con blocchi poligonali di
pietra lavica, di cui un tratto è visibile in piazza Monfalcone.
Nel V secolo fu costruita una nuova cinta in blocchi squadrati.
Le
mura che oggi circondano lo sperone roccioso sono quelle costruite
dagli Spagnoli nel XVI secolo, ma sono visibili ampi tratti delle
mura del XIII secolo, in cui sono stati reimpiegata blocchi della
cinta muraria greca.
La
torre in filari regolari di blocchi squadrati, decrescente verso
l’alto, è, invece, del IV secolo a.C.
Sul
promontorio del Castello sono state messe in luce vestigia delle
città romana, greca e dei villaggi preistorici e protostorici che
le hanno precedute.
Tra
la Cattedrale e la Chiesa di Santa Caterina si incentrarono gli
scavi, di cui gli strati più recenti misero in luce un quartiere
di abitazioni di epoca ellenistico-romana, del II secolo a.C., a
pianta regolare, a scacchiera, di cui si individua il reticolato
stradale, composto da decumani
e cardines.
Dallo
scavo sono stati messi in luce parte del Decumano massimo, che
coincide quasi perfettamente con la strada attuale, passante per
l’acropoli (l’area del Castello), e due cardines.
Delle
case che occupavano le insulae
si sono conservate scerse tracce, limitate soltanto ad alcuni muri
perimetrali.
Pochissimi
sono i resti della città greca venuti alla luce. Il primo
insediamento era sicuramente sull’acropoli, l’area del
Castello, circondata da poderose mura.
Delle
abitazioni della città greca non si sono conservate tracce, né
si trovò nulla di altri resti edilizi, fatta eccezione per alcune
cisterne e alcune fosse votive, relative a qualche edificio sacro,
sull’acropoli. Tra queste fosse votive va sicuramente messo in
evidenza il cosiddetto bothros
(pozzo votivo) di Eolo, dalle dimensioni considerevoli (m.
6.40 di profondità per m. 3.15 di larghezza). La parte inferiore
è tagliata nella roccia, la bocca era invece chiusa con un
coperchio in pietra lavica su cui è scolpito un leone
accovacciato (attualmente conservato nella Sala X del Museo
Archeologico).
Nel
bothros, scoperto nel 1964, furono scoperti numerosi vasi in
frammenti (rotti volutamente in senso rituale) e altri oggetti
interpretabili come ex-voto databili tra la metà del VI e la fine
del V secolo a.C. Grazie all’iscrizione AIO[LOU
(Trad.: di Eolo)
graffita su un’olpe si è identificata la divinità, a cui il
pozzo votivo era dedicato, con Eolo.
Molti
sono i rinvenimenti ceramici di epoca greca e romana, provenienti
soprattutto dalle tombe della necropoli greco-romana in contrada
Diana, ma anche dalla discarica ai piedi del muro in opera
poligonale di Piazza Monfalcone. Si tratta di ceramiche corinzie,
attiche, rodie, laconiche, ioniche, dei secoli VI – V a.C.
Un
pezzo notevole è costituito dalla testa di un acrolito, in marmo,
pertinente, con molta probabilità, a una statua cultuale.
Sempre
sull’acropoli del Castello, sotto le case del periodo
ellenistico-romane si sviluppano gli strati delle fasi
preistoriche, di cui sono state trovate i focolari, le capanne,
individuabili in recinti circolari e ovali di pietre, che
costituivano lo zoccolo delle stesse, purtroppo mal conservate.
Presso il lato nord sono i resti di una grande capanna (m.
15x7.50), dell’Ausonio II, preceduta da un portico e con la
parete di fondo absidato.
Queste
capanne erano semi infossate, avevano lo zoccolo in pietrame unito
a secco, l’alzato in gran parte in legname e il tetto, sorretto
da pali lignei, in stoppie forse
rivestite con impasto di argilla e paglia.
Si
sono scoperti cospicui resti di un villaggio del Milazzese,
costituito da capanne ovali che circondano una capanna maggiore,
sempre ovale, chiusa entro un recinto quadrangolare, su cui è
posta una capanna dell’Ausonio II.
Seguono
in sezione altre capanne dell’età del Bronzo, e affiorano gli
strati neolitici in cui sono stati raccolti molti reperti
ceramici, conservati nelle sale I e II del Museo. Al di sotto
degli strati neolitici è uno strato sterile e poi la roccia.
Subito
fuori dalle mura, nella contrada Diana si estese la necropoli, nei
pressi della quale sorse l’area sacra a Demetra e Kore, le
divinità ctonie.
In
epoca romana sorsero divenne colonia augustea e vi furono
costruite delle ricche domus, con mosaici pavimentali e un’arena, costituita da un
recinto di forma ovale, circondato da un muro, e con sedili
lignei, ritrovata presso il “Cinema Eolo”.
Al
di sotto dell’arena sono state rinvenute tracce di un altare di
V-IV sec. a.C., con molta probabilità pertinente a un santuario
di Demetra e Kore (Persefone), di cui sono state scoperte anche
numerosi pozzi votivi (bothroi),
contenenti terrecotte di IV-III sec. a.C., tra cui busti delle dee
recanti un porcellino (uno dei loro attributi). Nell’area di
questo santuario sono stati scoperti anche numerosi pinakes
rappresentanti divinità femminili, in cui sono identificabili
Cibale, Kore, Hera (?), o sacerdotesse che compiono riti sacri,
danzatrici e suonatrici.
Oltre
a ciò, scarse sono le tracce della città romana, più ricche
invece quelle della sua necropoli, impiantata su quella greca, in
contrada Diana, di cui spesso riutilizza le sepolture. Le tombe
sono riunite in raggruppamenti interni, tutte rivolte con la testa
a sud, in filari pressoché regolari.
Il
rituale greco presenta, per la maggioranza, tombe a inumazione, ma
ci sono anche sepolture a cremazione. Molte le inumazioni in
sarcofago (a lastroni di pietra, soprattutto; ma anche a bauletto;
in terracotta, cotti in un solo pezzo;) o in mattoni crudi,
coperti da una lastra di pietra. Le inumazioni dei bambini sono in
skaphe (culla) a forma di vasca, in terracotta.
Sono
attestate delle tombe alla cappuccina, che presentano dei corredi
più poveri. I corredi sono sempre esterni, racchiusi entro vasi
di una certa grandezza di varie forme (anfore, pithoi, stamnoi,
crateri, ecc.). Altre volte in questi vasi sono contenuti i resti
delle cremazioni.
Altre
tombe, comprese tra il IV e il III secolo a.C. (precedenti
all’occupazione della città da parte dei romani) hanno
restituito tombe a inumazione entro sarcofagi litici, più curati
dei precedenti, dipinti o stuccati all’interno.
Talvolta
le tombe più ricche presentano due corredi, uno interno e uno
esterno. In queste tombe sono stati rinvenuti i vasi figurati,
oggi conservati al Museo di Lipari.
Le
tombe successive alla conquista romana dell’isola (comprese tra
il III e il I sec. a.C.) sono caratterizzate da corredi molto
poveri e sono quasi tutte “alla cappuccina”. In corredo si
riduce a pochi vasi di argilla grezza. Più frequenti i
rinvenimenti di piccoli oggetti di oreficeria.
In
età augustea si diffonde l’uso di riusare i sarcofagi greci per
contenere nuove inumazioni, ma anche quello di costruire tombe
monumentali (entro recinti, a camera ipogea) appartenenti a
persone della stessa famiglia.
Altri
gruppi di tombe sono stati rinvenuti nelle contrade di Pertinenti
e Sant’Anna. Inoltre, presso la collina di San Nicola
sono stati ritrovate tombe familiari ipogee, con nicchie e loculi
per contenere urne e sarcofagi.
Delle
necropoli di epoca cristiana abbiamo delle tombe polisomi (per più
corpi).
La
coroplastica di Lipari ci ha lasciato centinaia di terrecotte
figurate di argomento teatrale, ma si tratta, anche in questo
caso, di offerte funerarie (si trovano, infatti, in tombe del IV
secolo a.C.), essendo un simbolo del culto di Dioniso, il cui
culto a Lipari doveva essere ampiamente diffuso. Si tratta di
maschere della tragedia e della commedia greca, cui si aggiungono
maschere a carattere satiresco.
Dai
numerosi scavi subacquei presso le isole Eolie sono stati
rinvenuti molto reperti provenienti da relitti naufragati in varie
epoche nei punti più insidiosi dell’arcipelago. Le navi non si
sono conservate, ma resta il carico, composto soprattutto da
anfore, ma anche ceramiche e parti della nave in materiale non
deperibile, come le anfore.
Fra
i relitti rinvenuti nei pressi di Lipari è da ricordare quello
scoperto presso la Secca di Capistello contenente anfore
greco-italiche e ceramica a vernice nera.
In
quest’isola è da ricordare un insediamento preistorico in
località Ginostra, che ha restituito frammenti ceramici dello
stile di Capo Graziano. Nella stessa area sono stati rinvenuti
frammenti ceramici di epoca ellenistico-romana, mentre
insediamenti di età classica sono nei pressi della chiesa di San
Vincenzo e a Labronzo. In località Scari è stata scoperta una
necropoli con tombe del IV-III secolo a.C.
L’isola
di Panarea è stata abitata sin dal Neolitico. Sono state
rinvenute ceramiche dello stile di Serra d’Alto e dello stile di
Diana, e, riferiti alla stessa fase, numerosi frammenti di selce,
alcuni adoperati come cuspidi di frecce, raccolti sul punto più
alto dell’isola, a Timpone del Corvo, pertinenti a un luogo di
culto.
Dello
stesso periodo è il giacimento di ceramiche, selci e ossidiana
rinvenuto in località Calcara, un a conca sulla costa di N/E
aperta verso il mare, di non facile accesso. Nella zona di Piano
Quartara sono state rinvenute tracce di uno stanziamento della
fase che proprio da questo sito prende
il nome (2000 a.C.).
Resti
riferibili alla cultura di Capo Graziano (secoli XVIII – XVII
fino al 1400 a.C.) sono stati trovati sulla Punta di Peppa Maria e
il località Calcara, in cui sono stati messi in luce dei pozzetti
circolari, resi con grossi ciottoli uniti da fango vulcanico.
Probabilmente questi pozzetti erano destinati alla conservazione
di cereali e altre derrate alimentari.
Sopra
questi era uno strato di epoca greca e romana ricco di ceramica a
vernice nera (dal IV al I secolo a.C.) e ceramica romana (del I-II
secolo d.C.).
Sempre
su quest’isola è un altro insediamento noto come Punta del
Milazzese che da il nome alla facies
omonima. Il villaggio è posto su un promontorio a SW/E
dell’isola, con pareti verticali, perciò naturalmente
fortificato. In questa zona sono state messe in luce alcune
capanne ovali, tranne una rettangolare, alcune delle quali chiuse
entro un recinto, forse utilizzato come deposito delle provviste.
Alcune di queste capanne mostrarono un piano lastricato
all’interno e delle banchine lungo le pareti, e vi furono
rinvenuti mortai, macine, lastroni in pietra che ne costituivano
l’arredamento.
Il
villaggio è stato sottoposto a una distruzione brutale e
improvvisa, come dimostra il fatto di aver ritrovato i vasi
all’interno delle capanne. Le ceramiche ivi rinvenute sono
quelle che caratterizzano la facies,
si tratta quindi di tazze su alto piede tubolare, bottiglie
ovoidali, frammenti di grandi orci a nervature, piccoli pithoi a
sei anse, orci ovoidali e biconici, fruttiere su piede conico,
grandi teglie. Inoltre, piccoli vasetti, corni-amuleti, fuseruole,
uncini, alari. Sono, infine, da ricordare alcune ceramiche di
importazione dalla penisola italiana, attribuibili alla civiltà
appenninica, e ceramiche micenee.
Non
sono stati, finora, ritrovati siti riferibili alla tarda età del
Bronzo e alla prima età del Ferro, segno che dopo la distruzione
del villaggio del Milazzese l’isola è rimasta pressoché
disabitata.
In
località Castello del Salvamento sono stati rinvenuti frammenti
ceramici di età greca (V secolo a.C.). In vari punti dell’isola
sono stati trovati frammenti ceramici a vernice nera di epoca
ellenistica e romana, mentre sulla Punta di Peppa Maria sono stati
individuati resti di modeste case romane.
Presso
le spiagge di San Pietro e Drauto sono state scoperte numerose
tombe riferibili all’età romana (I secolo d.C.).
Nell’isolotto
di Lisca Bianca sono stati rinvenuti frammenti di ceramica di
epoca ellenistico-romana. Nell’isolotto di Basiluzzo sono stati
trovati anche frammenti ceramici di impasto preistorico, frammenti
di epoca ellenistico-romana e una stele funeraria del IV secolo
a.C. e resti di una villa romana con mosaici pavimentali e un
piccolo approdo (darsena) in calcestruzzo, oggi sommerso dal mare.
Anticamente
era denominata Hierà,
sacra, ma anche Hierà
Ephaistou (sacra ad Efesto, il fabbro degli dei, che pare che
avesse la sua officina sotto un vulcano), però sull'isola non
sono state rintracciate testimonianze di culto offerte a questa
divinità, né, allo stato delle attuali conoscenze, sappiamo di
abitati di epoca antica sull’isola.
Presso
Punta Crapazza, fra Lipari e Vulcano, è stato scoperto un relitto
di età imperiale romana che ha restituito un carico di lingotti
di stagno di probabile provenienza spagnola.
Il
suo nome antico era Didyme,
che significa “gemelli”, deve questo nome dei due vulcani
dell’isola, ormai spenti: Fossa delle Felci e Monte dei Porri.
Il nome attuale deriva da un laghetto dal quale si estraeva il
sale.
In
località Malfa è stata scoperta una tomba risalente all’età
dei metalli (seconda metà del III millennio a.C.), che ha
restituito alcuni vasetti decorati con punti impressi e frammenti
di ossidiana.
In
località Serro dei Cianfi sono state evidenziate tracce di un
insediamento delle fasi di Capo Graziano e del Milazzese, di cui
è stato rinvenuto soltanto un accumulo di terreno ricco di
reperti ceramici, fra cui, oltre quelle delle fasi in esame, molte
ceramiche di importazione.
In
località La Portella è stato trovato un abitato immediatamente
seguente a quello di Serro di Cianfi, non più adatto alla difesa
della popolazione. La nuova sistemazione offriva una condizione più
favorevole, essendo naturalmente difeso, posto tra due canali
dovuti all’erosione. Le capanne, ivi ritrovate, sono circolari,
seminterrate, erose dal lato volto verso il mare. Esse presentano
forti segni di distruzione violenta. Sono stati scoperti molti
pithoi, orci, teglie, fruttiere tipiche del periodo, coppe su alto
piede tubolare, olle, bottiglie, fuseruole, piccoli vasetti,
macine, mulinelli, pestelli, mortai; le ceramiche d’importazione
sono sia “appenniniche” che micenee. Di importazione micenea
è una lunga collana di pietra dura, pasta vitrea e pastiglie
bianche, azzurre e verdi.
Sul
dosso detto Serro d’Acqua sono stati rinvenute ceramiche del VI
– V secolo a.C. che sarebbero riferibili alle prime tracce
greche sull’isola.
Nella
zona di Santa Marina sono stati portati alla luce resti che vanno
dal IV sec. a.C. all’epoca romana imperiale, con resti di
abitazioni sulla riva del mare (oggi coperte dalla strada
costiera) e alcune tombe.
Varie
tracce riferibili a piccoli nuclei abitativi a carattere agricolo
del periodo romano sono stati portati alla luce in vari punti
dell’isola, di cui restano tombe a cappuccina e frammenti
ceramici; altrove sono stati trovate iscrizioni funerarie di età
ellenistica tarda.
L’antico nome di Filicudi
era Phoenicusa (cioè,
“ricca di felci”).
Sull’isola
sono state trovate ceramiche neolitiche dello stile di Diana (3000
a.C.), trovati presso il villaggio della Montagnola di Capo
Graziano. Ai secoli XVIII e XVII a.C. è riferibile il villaggio
di capanne ovali posto in località Piana del Porto. Le capanne
sono state costruite rozzamente, con grossi ciottoli, e hanno
subito numerose ricostruzioni. In questo villaggio sono state
rinvenute ceramiche della fase di Capo Graziano.
Immediatamente
successivo a questo abitato, è quello sulla Montagnola di Capo
Graziano che dà il nome alla facies.
Lo spostamento su questa zona, naturalmente fortificata, fu
sicuramente necessario a causa di attacchi nemici provenienti dal
mare.
Dagli
scavi sono venute alla luce delle capanne ovali, parzialmente
infossate, che recano tracce di rifacimenti successivi; esse sono
strutturalmente più curate di quelle della fase precedente di
Piana del Porto. Le ceramiche rinvenute in questo villaggio sono,
ovviamente, della fase di Capo Graziano, con alcuni ritrovamenti
minori della fase del Milazzese. Come ceramiche d’importazione
ci sono quelle egee (Miceneo I e II).
Anfratti
naturali sono stati adoperati da queste genti per le sepolture per
più individui, del tipo entro grotticelle artificiali, riferibili
alla fase abitativa più antica.
All’età
greca e romana sono riferibili scarse tracce di abitati
testimoniati da ceramiche a vernice nera e di terra sigillata
rinvenute in località Seccagni e Zuzzo Grande.
In
località Piano del Porto è stata scoperta una cisterna romana.
L'antico
nome Ericusa è dovuto
alla ricca vegetazione di erica dell’isola.
Qui
è stato scoperto un abitato della fase di Capo Graziano, presso
la zona del Porto e in contrada Pantalucci e contrada Fucile, e in
altre zone piane dell’isola corrispondenti ad antichi crateri.
Lungo
tutta la costa est dell’isola sono state rinvenute ceramiche di
epoca romana.
|
|